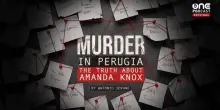s

Cultura e Spettacolo
Cento anni fa nasceva Camilleri. Mattarella: "Prezioso il suo lascito culturale"
06-09-2025, 12:36
AGI - Il 6 settembre del 1925 nasceva Andrea Camilleri, l'autore destinato a rivoluzionare la letteratura italiana. "Camilleri si è distinto per la sua creatività, raffigurando personaggi e scenari, talora immaginari, che nello stesso tempo tratteggiano spaccati di diverse epoche. Il lascito culturale di Camilleri è un bagaglio prezioso", ha commentato Sergio Mattarella nella dichiarazione in cui il Presidente della Repubblica osserva anche che "il centenario della nascita di Andrea Camilleri consente di ricordare una figura di primo piano del panorama culturale italiano e internazionale. Numerose sue opere continueranno a essere fonte di ispirazione per generazioni di lettori e di scrittori". "Andrea Camilleri è stato un autore poliedrico che ha offerto un contributo significativo nei molteplici ambiti in cui ha operato, spaziando dal teatro alla televisione, alla narrativa. Ha saputo coniugare trame poliziesche e raffinata verve umoristica, in cui un linguaggio complesso, in cui - rileva ancora Mattarella - gioca un ruolo il dialetto della sua Sicilia, ha permesso di rappresentare la ricchezza e la complessità del patrimonio etnografico della sua terra natia a un crescente gruppo di appassionati". Il dialetto tra le mura di casa Lo scrittore di Porto Empedocle rimane per gli italiani l’autore che più di ogni altro ha saputo trasformare il dialetto in strumento narrativo. La sua lingua “ibrida”, che mescola siciliano e italiano, ha dato voce al commissario Montalbano e ha reso riconoscibile uno stile unico. Ha fatto emergere la scrittura di genere dall'esilio nelle edicole e a restituire dignità letteraria al dialetto, quella che lui stesso definiva "la lingua degli affetti". Secondo una ricerca condotta da Excellera Intelligence per Audible, l’85% degli italiani conosce Camilleri e il 71% ammette di aver trovato qualche difficoltà nella comprensione della sua lingua. Nonostante ciò, per quasi 9 italiani su 10 (l’89% degli intervistati) il dialetto è un vero e proprio caposaldo della cultura italiana, mentre il 79% lo considera un ponte tra generazioni. Solo una minoranza, il 15%, lo vede come uno strumento superato e quasi la metà (46%) pensa che venga parlato soprattutto dagli anziani. Nonostante questa percezione, il dialetto resta vivo soprattutto nei momenti di intimità: due italiani su tre lo usano in famiglia (55%) o tra amici (49%), per dar forza a espressioni che non avrebbero lo stesso impatto in italiano standard. Il 42% lo utilizza per battute ed espressioni divertenti, il 34% per trasmettere emozioni forti. È la conferma di quanto sosteneva lo stesso Camilleri, che definiva il dialetto “la lingua del cuore, un fatto confidenziale, intimo, familiare”. Il rapporto con i dialetti varia a seconda delle generazioni. I più giovani si dichiarano più competenti in inglese che nella parlata regionale (6,9 contro 5,9), mentre con l’età la tendenza si ribalta: tra gli adulti il dialetto raggiunge una media di conoscenza di 6,7, superando nettamente l’inglese (4,6). Anche a livello geografico emergono differenze: l’unica area in cui l’inglese prevale è il Nord-Ovest (5,8 contro 5,5), mentre nel Nord-Est, al Centro e soprattutto al Sud e nelle Isole è il dialetto a dominare (7 di media contro 5,5 per l’inglese). Quanto ai gusti, gli italiani premiano il romanesco (39%) e il napoletano (38%), seguiti dai dialetti toscani (31%), dal siciliano (24%) e dal romagnolo (22%). Non solo Camilleri Non a caso, insieme a Camilleri, gli autori più ricordati per l’uso del dialetto sono Trilussa, con la sua satira in romanesco, ed Eduardo De Filippo, che ha fatto del napoletano un linguaggio teatrale universale. Ma la lista è lunga: da Carlo Porta, che con il milanese dipinse la società ottocentesca, a Pier Paolo Pasolini, che mescolò italiano e friulano nei suoi primi esperimenti poetici, fino a Dario Fo, che rese il grammelot e i dialetti lombardi strumenti di teatro popolare e politico. L’uso letterario del dialetto, insomma, non è un vezzo folcloristico ma una scelta consapevole: serve a restituire l’autenticità di un mondo, a rendere le emozioni più immediate, a dare ritmo e musicalità a un racconto. Non sorprende, allora, che il 67% degli intervistati auspichi un recupero del dialetto nella conversazione quotidiana e che più della metà (54%) si dichiari favorevole al suo insegnamento nelle scuole. Un patrimonio da riscoprire Oggi, i contenuti in dialetto restano marginali: solo il 3-4% degli italiani dichiara di fruirne regolarmente, mentre la lettura di testi dialettali coinvolge il 19% e la visione di film o spettacoli in dialetto arriva al 33%. Eppure la curiosità è forte: circa due italiani su tre si dicono interessati ad ascoltare racconti, fiabe, poesie e romanzi nella lingua della propria regione. Qui entra in gioco, a margine, anche il mondo degli audiolibri: il 64% del campione ritiene che possano facilitare la comprensione del dialetto e l’86% vede in queste produzioni un mezzo per valorizzare la cultura regionale. In definitiva, il dialetto resiste come patrimonio culturale ed emotivo. Non è solo memoria del passato, ma anche strumento per raccontare il presente e costruire identità condivisa. Camilleri ha mostrato che può diventare letteratura di successo; altri autori che può farsi teatro, poesia, satira. E gli italiani, tra nostalgia e curiosità, sembrano pronti a riscoprirlo come lingua che non divide, ma unisce.
CONTINUA A LEGGERE

16

0

0