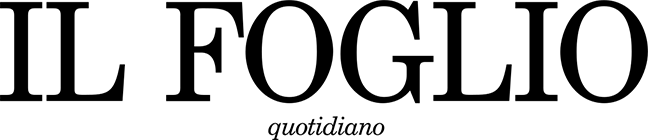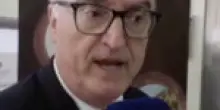s

Economia e Finanza
L’economia è per tutti. Basta dare retta al precettore Sergio Ricossa
Oggi 17-09-25, 06:57
Pubblichiamo un estratto dell’Introduzione di Carlo Stagnaro (che è anche curatore del volume) a “I grandi classici dell’economia” di Sergio Ricossa, in libreria per Liberilibri (464 pp., 20 euro) Parafrasando ciò che lui stesso scrisse di Friedrich von Hayek – vincitore del premio Nobel per l’economia nel 1974 – si potrebbe dire che vi sono tre Ricossa: l’economista, il precettore e il divulgatore. Il primo e il terzo sono i meglio conosciuti; il secondo è l’artefice di questo libro. Il nome di Sergio Ricossa (1927-2016) divenne noto agli italiani soprattutto per la copiosa produzione giornalistica: il suo primo articolo, intitolato “Liberali liberisti libertini”, comparve il 15 agosto 1951 sulla rivista Rinnovamento liberale; continuò a scrivere finché poté. Per Ricossa, il mondo va interpretato alla luce dello scontro tra i perfettisti, che ritengono di sapere cosa è meglio per gli altri (e si considera pertanto autorizzato a imporglielo), e gli imperfettisti, secondo cui la libertà, la tolleranza e il pluralismo siano gli ingredienti irrinunciabili di una società dinamica e prospera. Il Ricossa economista è sia eretico sia rivoluzionario: eretico perché nel tempo si discosta da quell’economia neoclassica che inizialmente aveva abbracciato, vedendo persino lì il germe del perfettismo; rivoluzionario perché torna al punto di partenza, cioè alla giunzione tra economia e filosofia. Di queste convinzioni si nutre il Ricossa corsivista. Ma questi due sono tenuti assieme da un terzo e meno ovvio Ricossa: il pedagogo che si impegna a spiegare l’economia a un paese che ne è digiuno. Tale interesse per la diffusione delle idee si è tradotto in un lungo e sistematico lavoro che si è declinato su più piani, passando da opere di taglio sofisticato fino ad altre, come appunto questo libro, pensate per avere una circolazione più “popolare”. L’obiettivo di Ricossa, con I grandi classici dell’economia che viene oggi ripubblicato e aggiornato, è proporre al lettore cento brevi recensioni, scelte sulla base della sensibilità e del “criterio soggettivo del selezionatore”: “Vi sono autori, come Adam Smith, Karl Marx e John Maynard Keynes, che nessuno escluderebbe, ma ve ne sono molti altri che sono al margine, per cui dipende da un nonnulla metterli al di qua o al di là della linea di divisione”. Con questo volume, egli non intende scrivere “un libro in più da aggiungere alla serie sterminata che costituisce la biblioteca degli economisti” ma “estrarre dal mucchio immenso cento opere preminenti” che diano conto del dibattito, dei cambiamenti e persino delle innovazioni che gli economisti hanno nel tempo apportato alla loro disciplina. Dalla lettura si scopre che la riflessione economica esisteva ben prima che si potesse parlare di economia nel senso in cui intendiamo oggi. Ma si vede anche che “la letteratura economica, che per secoli era stata scarsa e scarna, si moltiplicò allora con crescente velocità anche perché essa non ebbe quasi mai fini esclusivamente scientifici pur quando pretendeva di averli, ma accendeva la passione politica (oltre che la passione religiosa) e divideva chi se ne occupava in partiti caratterizzati da ideologie diverse. Il partito favorevole all’intervento pubblico ebbe una certa prevalenza iniziale, quando pose la cosiddetta dottrina mercantilistica al servizio della formazione della monarchia assoluta che si stava consolidando all’uscita dal periodo feudale”. La moltiplicazione della letteratura non è altro che un’eco del bisogno di capire un mondo in trasformazione, da parte principalmente della classe – la borghesia – che di quella trasformazione era causa e protagonista. I grandi classici dell’economia è, dunque, una sorta di lasciapassare per il lettore non specialista ma interessato a comprendere “gli aspetti pedestri della vita: la produzione, il risparmio, l’investimento, il commercio”. Quegli aspetti, cioè, che rappresentano la base e forniscono il contesto all’interno del quale si svolgono “gli amori e le avventure”, più spesso oggetto delle fantasie dei romanzieri (sebbene, come spiega lo studioso torinese, vi possano essere punti di contatto persino tra la scienza oscura degli economisti e la magia luminosa degli scrittori). Questo volume è dunque l’equivalente di un’introduzione all’economia rivolta ai non esperti. Il lettore potrà osservare lo sviluppo continuo, il dialogo insistente, gli incontri e gli scontri tra intellettuali che hanno avuto successo, poi sono stati dimenticati e poi riscoperti; che hanno illuminato con le proprie intuizioni il sentiero dei contemporanei – consapevoli o no della loro influenza – e ne hanno accompagnato i passi nella buona e nella cattiva sorte. Potrà anche rilevare come domande ricorrenti si presentino nel lavoro degli economisti: da cosa nasce la crescita? Qual è il giusto ruolo dello stato? In che modo l’intervento pubblico può correggere le storture del mercato, e quale costo? Spesso gli economisti correggono, emendano o confutano le tesi di chi li ha preceduti: più spesso ancora, i contributi di ciascuno arricchiscono la comprensione della realtà, entrano in rapporto dialogico con quelli degli altri, di cui evidenziano le intuizioni e i limiti. Sebbene Ricossa sia equilibrato nel presentare le trame, a cui in questa nuova edizione ne vengono aggiunte altre trentatré per dare conto dell’evoluzione successiva all’edizione originaria (1990), non fa mistero delle proprie simpatie. In ultima analisi giunge alla conclusione che, se la perfezione non è di questo mondo, non lo è neppure l’onniscienza: e dunque il progresso scientifico nasce dal lento, costante e apparentemente infruttuoso scavare quella montagna insondabile che è l’essere umano, consentendo a chi viene dopo di imparare da chi è venuto prima. Come scrisse Ricossa in quel primo articolo del 1951, nel quale affonda e dal quale deriva tutta la produzione successiva: “accertate alcune premesse (condizioni di libera concorrenza) il liberismo è il sistema più produttivo perché il meno utopistico, quello più basato sulla realtà della natura umana, senza ipocrisie ed illusioni. L’uomo medio è quello che è”.
CONTINUA A LEGGERE

2

0

0
Guarda anche
Il Foglio
06:40
Micillo&Sportiello, i dioscuri di Fico nella corsa in Campania
Il Foglio
06:27
Taglio ai tassi e all'indipendenza della Fed
Il Foglio
06:25